Una crociata
Un universo che possa continuare indefinitamente in attività e il Secondo Principio della Termodinamica
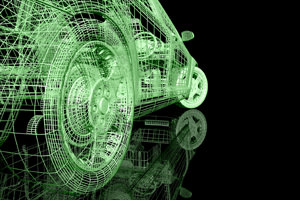
Chiunque desideri un universo che possa continuare indefinitamente in attività, deve intraprendere una crociata contro il Secondo Principio della Termodinamica. (A.S.Eddington, The Nature of the physical world, Cambridge, University Press 1929)
Nel 1775, l'Accademia delle Scienze di Parigi, il sommo esponente scientifico francese, offriva un premio di 500.000 Franchi a chi trovasse una macchina che funzionasse da sola producendo lavoro e ciò indefinitamente senz'altro impulso esterno. (cfr. E.Guarini, L'utilizzazione del calore ambiente come forza motrice, pg. 8 (Bibl. CNR , P.le A.Moro 1, Roma - collocazione TJ260.G931) Si presume, da tale citazione, trattarsi di una macchina che realizzi un perpetuum mobile di prima specie e pertanto di una macchina irrealizzabile, stando al fatto che l'energia si può trasformare ma non creare dal nulla. Il perpetuum mobile di seconda specie consiste, invece, nella utilizzazione dell'energia interna dei corpi e cioè del calore accumulatovi dal sole o di quello prodotto dalla combustione del petrolio o dei gas naturali. Non si tratta, quindi, di creare energia ma di trasformarla. Se la soluzione del problema del movimento perpetuo di seconda specie non ha fatto grandi progressi lo si deve al fatto che i rappresentanti della scienza ufficiale hanno decretato - magister dixit - che siccome le leggi fondamentali della Termodinamica vi si oppongono, il problema non ha soluzione ed ogni tentativo sperimentale sarebbe senz'altro sterile (cfr. E. Guarini,op. cit., pg. 8).
Riguardo a tali leggi fondamentali della termodinamica è da tener ben presente che in tutti i rami della Fisica Applicata, disciplina che è il fondamento di tutte le macchine, i "rendimenti (efficienze)" delle macchine che utilizzano fonti energetiche diverse dall’energia termica, come quella idraulica o quella elettrica, vengono calcolati facendo il rapporto tra il lavoro prodotto e la differenza tra l’energia introdotta nella macchina e quella restituita dalla macchina stessa; il rendimento di queste macchine, calcolato in questo modo, risulta sempre pressoché eguale all’unità. Le fonti energetiche, relative a tali macchine non-termiche, vengono considerate "di prima specie", in conseguenza a tale valore del rendimento. Venne però introdotta da N.L.S. Carnot (1796-1832), nei primi anni del XIX secolo, per il calcolo del rendimento di una macchina che utilizzi l’energia termica, una formula matematica che non tiene in alcun conto dell’energia restituita, dalla stessa macchina, a temperatura più bassa: il rendimento di queste macchine risulta, conseguentemente, tanto più prossimo all’unità quanto maggiore sarà il rapporto tra la temperatura in entrata e quella in uscita. Ferma restando la temperatura minima all’uscita (...), stabilita di massima dalle condizioni ambientali, tale rendimento presenta valori prossimi all’unità (...) solo per temperature all’ingresso decisamente elevate e vicine al limite superiore della resistenza termica dei materiali (...). Le alte temperature di ingresso, così stabilite, fanno sì che il rendimento effettivo degli attuali motori termici passi poi, praticamente, dal 98% al 20% circa, non per una congenita menomazione del calore rispetto alle altre forme di energia, ma per le elevate dispersioni termiche e per i necessari raffreddamenti, delle parti meccaniche interessate alla trasformazione: il 35% non viene utilizzato perché sottratto dall’acqua di raffreddamento e dall’olio, il 10% viene disperso in attrito, il 35% nei gas di scarico (cfr. W.H.Crouse, Automotive Engine Design, McGrow-Hill Book Co. 1970, pg. 76).
Se, contrariamente a quanto è stato fatto fino ad ora, anche per le macchine termiche venisse applicato lo stesso criterio di rendimento che viene usato per le macchine idrauliche ed elettriche, anche il rendimento delle macchine termiche, risulterebbe pressoché uguale all’unità, qualunque sia il salto di temperatura utilizzato. Motori che utilizzassero salti termici decisamente inferiori pertanto, anche se, per fornire la stessa potenza, risulterebbero costruttivamente di dimensioni maggiori, ma comunque tali da poter essere impiegati per la produzione di energia elettrica a terra, potrebbero avere rendimenti effettivi di gran lunga superiori a quelli attuali dei quali si è considerato, fino ad ora, insuperabile il rendimento da essi raggiunto.
Il raggruppamento di tutte le forme di energia in un’unica specie, ovvero l’equiparazione dell’energia termica alle altre forme di energia dette di prima specie, oltre a sanare molteplici ambiguità in campo fisico, potrebbe dar luogo ad una visione analoga, tra Oriente ed Occidente, per ciò che riguarda la Teleologia dell’universo. Buona parte dell’Ingegneria, invece, cioè di quella attività che dovrebbe essere Scienza Applicata al servizio dell’uomo e pertanto Umanesimo, risente di questa anomalia, frutto di una cultura di parte "occidentale" e pertanto né "globale", né "planetaria", né "cosmica", né, che ne è un sinonimo, "Cattolica".
Nel 1775, l'Accademia delle Scienze di Parigi, il sommo esponente scientifico francese, offriva un premio di 500.000 Franchi a chi trovasse una macchina che funzionasse da sola producendo lavoro e ciò indefinitamente senz'altro impulso esterno. (cfr. E.Guarini, L'utilizzazione del calore ambiente come forza motrice, pg. 8 (Bibl. CNR , P.le A.Moro 1, Roma - collocazione TJ260.G931) Si presume, da tale citazione, trattarsi di una macchina che realizzi un perpetuum mobile di prima specie e pertanto di una macchina irrealizzabile, stando al fatto che l'energia si può trasformare ma non creare dal nulla. Il perpetuum mobile di seconda specie consiste, invece, nella utilizzazione dell'energia interna dei corpi e cioè del calore accumulatovi dal sole o di quello prodotto dalla combustione del petrolio o dei gas naturali. Non si tratta, quindi, di creare energia ma di trasformarla. Se la soluzione del problema del movimento perpetuo di seconda specie non ha fatto grandi progressi lo si deve al fatto che i rappresentanti della scienza ufficiale hanno decretato - magister dixit - che siccome le leggi fondamentali della Termodinamica vi si oppongono, il problema non ha soluzione ed ogni tentativo sperimentale sarebbe senz'altro sterile (cfr. E. Guarini,op. cit., pg. 8).
Riguardo a tali leggi fondamentali della termodinamica è da tener ben presente che in tutti i rami della Fisica Applicata, disciplina che è il fondamento di tutte le macchine, i "rendimenti (efficienze)" delle macchine che utilizzano fonti energetiche diverse dall’energia termica, come quella idraulica o quella elettrica, vengono calcolati facendo il rapporto tra il lavoro prodotto e la differenza tra l’energia introdotta nella macchina e quella restituita dalla macchina stessa; il rendimento di queste macchine, calcolato in questo modo, risulta sempre pressoché eguale all’unità. Le fonti energetiche, relative a tali macchine non-termiche, vengono considerate "di prima specie", in conseguenza a tale valore del rendimento. Venne però introdotta da N.L.S. Carnot (1796-1832), nei primi anni del XIX secolo, per il calcolo del rendimento di una macchina che utilizzi l’energia termica, una formula matematica che non tiene in alcun conto dell’energia restituita, dalla stessa macchina, a temperatura più bassa: il rendimento di queste macchine risulta, conseguentemente, tanto più prossimo all’unità quanto maggiore sarà il rapporto tra la temperatura in entrata e quella in uscita. Ferma restando la temperatura minima all’uscita (...), stabilita di massima dalle condizioni ambientali, tale rendimento presenta valori prossimi all’unità (...) solo per temperature all’ingresso decisamente elevate e vicine al limite superiore della resistenza termica dei materiali (...). Le alte temperature di ingresso, così stabilite, fanno sì che il rendimento effettivo degli attuali motori termici passi poi, praticamente, dal 98% al 20% circa, non per una congenita menomazione del calore rispetto alle altre forme di energia, ma per le elevate dispersioni termiche e per i necessari raffreddamenti, delle parti meccaniche interessate alla trasformazione: il 35% non viene utilizzato perché sottratto dall’acqua di raffreddamento e dall’olio, il 10% viene disperso in attrito, il 35% nei gas di scarico (cfr. W.H.Crouse, Automotive Engine Design, McGrow-Hill Book Co. 1970, pg. 76).
Se, contrariamente a quanto è stato fatto fino ad ora, anche per le macchine termiche venisse applicato lo stesso criterio di rendimento che viene usato per le macchine idrauliche ed elettriche, anche il rendimento delle macchine termiche, risulterebbe pressoché uguale all’unità, qualunque sia il salto di temperatura utilizzato. Motori che utilizzassero salti termici decisamente inferiori pertanto, anche se, per fornire la stessa potenza, risulterebbero costruttivamente di dimensioni maggiori, ma comunque tali da poter essere impiegati per la produzione di energia elettrica a terra, potrebbero avere rendimenti effettivi di gran lunga superiori a quelli attuali dei quali si è considerato, fino ad ora, insuperabile il rendimento da essi raggiunto.
Il raggruppamento di tutte le forme di energia in un’unica specie, ovvero l’equiparazione dell’energia termica alle altre forme di energia dette di prima specie, oltre a sanare molteplici ambiguità in campo fisico, potrebbe dar luogo ad una visione analoga, tra Oriente ed Occidente, per ciò che riguarda la Teleologia dell’universo. Buona parte dell’Ingegneria, invece, cioè di quella attività che dovrebbe essere Scienza Applicata al servizio dell’uomo e pertanto Umanesimo, risente di questa anomalia, frutto di una cultura di parte "occidentale" e pertanto né "globale", né "planetaria", né "cosmica", né, che ne è un sinonimo, "Cattolica".
Articolo del: