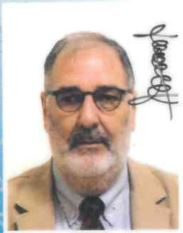L’accollo in ambito civile e tributario: quando ci si può liberare dai debiti?

L’art. 1273 del codice civile disciplina una particolare convenzione, definita “accollo” che consente, in materia civilistica e tributaria, di modificare il soggetto passivo su cui gravano le imposte oppure di affiancare a quest’ultimo un terzo soggetto (in materia di tributi).
In ambito civile, attraverso l’accollo il debito può essere trasferito dal debitore iniziale a un terzo, mentre in ambito tributario l’accollo è previsto senza però la liberazione del debitore.
Vediamo come partendo dalla definizione di accollo per poi illustrarne le varie tipologie e, infine, come è previsto l’accollo per i debiti nei confronti del fisco e degli enti locali.
Indice:
Cos’è l’accollo?
L’accollo è un contratto in base al quale un debitore (detto accollato) e un terzo (detto accollante) si accordano in modo che il debito sia assunto da quest’ultimo (accollante) in favore del creditore (accollatario).
La disciplina di tale istituto è contenuta nell’art. 1273 del codice civile descrivendo l’accollo come un contratto con cui “il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro”.
Nell’accollo, dunque, compaiono tre soggetti:
1. Il soggetto passivo (debitore) che ha un debito con l’erario (accollato);
2. Un soggetto terzo che si assume il pagamento (totale o in solido in base al tipo di accollo) del debitore (accollante);
3. Il creditore che deve riscuotere il credito (accollatario).
Nella stipulazione dell’accollo non è necessario il coinvolgimento del creditore (che può restarne estraneo), ma in base alla sua partecipazione, si generano due tipologie di accollo: accollo interno o accollo esterno.
Ugualmente, nell’accollo l’accollante (ovvero il terzo) può decidere di liberare il debitore originario oppure di contribuire parzialmente o ancora in solido, generando altre due tipologie di accollo: accollo liberatorio o accollo cumulativo.
Accollo interno
Non disciplinato direttamente dal codice civile, l’accollo interno è un contratto stipulato esclusivamente tra debitore e terzo in cui quest’ultimo si assume l’onere di pagare eventualmente il debito al posto del soggetto passivo.
Tale tipo di accollo è un accordo in cui il creditore è escluso e ciò ha delle conseguenze sulla riscossione del credito. Infatti, il creditore dovrà agire nei soli confronti del debitore originario e non sull’accollante. Sarà, eventualmente, l’accollato (ovvero il debitore) a poter agire nei confronti dell’accollante tramite un’azione di regresso.
Accollo esterno
L’accollo esterno, invece, è la convenzione espressamente disciplinata dal codice civile in cui il creditore sottoscrive l’accordo siglato dal debitore e dal terzo.
Il primo comma dell’art. 1273 c.c. prescrive che “Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore”.
In altre parole, se debitore e terzo si accordano con il creditore, l’accordo non è più revocabile.
Sul punto, però, vi sono varie scuole d pensiero. Parte della dottrina interpreta l’accollo come un contratto a favore del terzo e conseguentemente si applica l’art. 1411 del c.c. in base al quale la revoca può essere effettuata dal solo stipulante, ovvero il debitore originario. In tale modo, l’accollo si trasformerebbe da esterno ad interno. Secondo un’altra corrente dottrinale il diritto di revoca dovrebbe aspettare sia all’accollato che all’accollante. Infine, in base a una terza tesi, trattandosi di un accordo bilaterale, la revoca deve essere decisa esclusivamente con il consenso da parte di accollato e accollante.
Ma con l’accollo esterno chi deve pagare? A chi dovrà rivolgersi il creditore per poter soddisfare il suo credito? Dipende se l’accollo è liberatorio oppure cumulativo.
L’accollo liberatorio
Il secondo comma dell’art. 1273 del codice civile recita: “L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo”.
In altre parole, il debitore originario è liberato dal pagamento del debito esclusivamente se è espressamente previsto dal contratto di accollo nei seguenti casi:
1. Accollato e accollante hanno subordinato la stipula del contratto di accollo alla liberazione del debitore e il creditore vi abbia accettato;
2. Sia lo stesso creditore che ha espressamente dichiarato di voler liberare il debitore (accollato) dal debito nel contratto di accollo.
In entrambi i casi, la conseguenza è che il creditore potrà richiedere il pagamento del debito esclusivamente all’accollante e non all’accollato che è stato contrattualmente liberato.
Sul punto, però, va aggiunto che il quarto comma, sempre dell’art. 1273 del codice civile recita: “In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta”.
Dunque, in base a tale comma, il terzo può:
1. Soddisfare il credito esclusivamente per la quota a lui imputabile in base al contratto di accollo e non in maniera totale (se il debito complessivo è più elevato);
2. Eccepire l’invalidità del contratto di accollo se è presente un vizio nell’accollo e, di conseguenza, rifiutarsi di adempiere.
Accollo cumulativo
Infine, l’accollo cumulativo è la convenzione in base alla quale il terzo si assume il pagamento del debito, ma in solido con il debitore che, a differenza del caso precedente, non viene liberato.
Nel terzo comma dell’art. 1273 del codice civile è prescritto che: “Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo”.
In tal caso, il creditore potrà rifarsi indipendentemente sul debitore (accollato) o sul terzo (accollante) per recuperare le somme dovute.
L’accollo in ambito tributario
La disciplina dell’accollo può essere utilizzata anche in ambito tributario quado i debiti in questione sono dovuti nei confronti dello Stato o di altri Enti locali (Regioni, Province, Comuni, ecc…).
L’accollo fiscale, però, a differenza dell’accollo previsto in sede civilistica tra privati, presenta delle differenze.
La prima è certamente quella di non prevedere l’accollo liberatorio.
Infatti in base all’art. 8, comma 2, della Legge del 27 luglio 2000, n. 212 (“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”) e pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2000, n. 117 è previsto che “E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario”.
Dunque, l’accollo in ambito tributario è consentito, ma accollato e accollante rispondono in solido dei debiti nei confronti del fisco.
Non solo. Altra differenza, è che nell’accollo fiscale non è necessaria la sottoscrizione del creditore (in questo caso del fisco o ente locale), ma basta semplicemente che gli venga notificato l'accordo.
Infine, in base al recente D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157) è stato previsto il divieto di compensazione del debito, per l’accollante, con i crediti vantati. Infatti, l’art. 1, comma 2, del Decreto-legge citato recita: “Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante”.
In caso di violazioni da parte dell’accollante (come prescrive il successivo comma 3), i versamenti effettuati si considerano come non avvenuti e vengono comminate le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ovvero:
• Per l’accollante è prevista una sanzione pari al 30% del credito se questo è esistente, oppure dal 100% al 200% del credito se questo è inesistente;
• Per l’accollato la sanzione è pari al 30% di quanto dovuto. Se i versamenti sono effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta alla metà, mentre se il ritardo non è superiore a quindici giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
Articolo del: