Successione legittima, cos'è e come funziona?
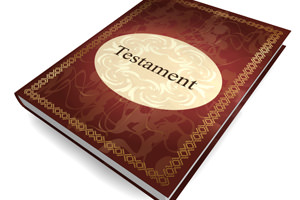
Succede spesso che un soggetto possa morire senza aver lasciato prima un testamento, ove aver indicato a chi destinare il proprio patrimonio.
In tutti questi casi è la stessa legge che interviene per disciplinare modalità e criteri da seguire, al fine di ripartire in modo equo tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al defunto, al momento della sua dipartita.
L’istituto giuridico che disciplina tali circostanze di fatto prende il nome di “successione legittima”, e viene disciplinato all’interno del Codice Civile agli articoli 565 e seguenti, ove nello specifico vengono indicati tutti i soggetti che verranno chiamati all’eredità (i c.d. legittimari), secondo un ordine ben preciso stabilito per legge e che privilegia il legame di parentela esistente con il defunto, favorendo quindi i legami affettivi più stretti, in ossequio al principio fondamentale di tutela della famiglia, previsto e disciplinato anche all’interno della nostra Carta Costituzionale all’art. 29.
Orbene, l’ordine di assegnazione dei cespiti ereditari, secondo le norme previste dal codice civile, dà priorità all’eventuale coniuge superstite, nonché alla presenza di figli, per poi successivamente dare spazio anche a tutti gli altri ascendenti e collaterali, fino al VI grado di parentela.
E’ opportuno a tal proposito precisare che, ad oggi, l’eventuale famiglia di fatto, composta quindi da soggetti conviventi non legati da un rapporto di coniugo, non rientra ancora nell’elenco dei possibili chiamati in linea di successione, ma nulla vieta che in futuro anche tale aspetto potrà eventualmente trovare la giusta regolamentazione da parte dell’ordinamento, visto il riconoscimento sempre più forte che, negli ultimi anni, ha portato il legislatore a disciplinare i rapporti affettivi diversi da quelli basati sul tradizionale schema di famiglia fondata sul matrimonio.
Orbene, solo quando ci si trovi nella condizione in cui non si rinvenga nessun soggetto con i requisiti di parentela innanzi detti, ecco quindi che entra in successione lo stesso Stato, il quale acquista di diritto l’eredità, solo al fine di garantire l’amministrazione dei rapporti patrimoniali afferenti il defunto, che altrimenti, di converso, risulterebbero privi di un effettivo titolare e non potrebbero ricevere alcuna legittima continuazione, determinando così un vulnus, le cui ripercussioni potrebbero interessare di conseguenza l’intera comunità.
Tanto premesso, la quota di “legittima” riservata ad ogni indicato soggetto legittimario, costituisce di per sé non solo un garanzia per il chiamato all’eredità, ma l’attribuzione di un vero e proprio diritto intangibile ed indisponibile all’attribuzione di una specifica quota del patrimonio ereditario, indipendentemente dalla volontà del defunto, in quanto è lo stesso Stato che determina la porzione di lascito da attribuire ad ogni singolo soggetto, a cui solo quest’ultimo può effettivamente rinunciarvi.
A tal proposito, si precisa in conclusione che, ad ogni soggetto chiamato all’eredità, viene data facoltà di accettare o meno il riferito lascito nel termine prescrizionale di dieci anni dalla data del decesso del de cuius, e ciò indipendentemente dal fatto che si tratti di successione con o senza testamento, salvo nel caso di successione dello Stato, ove l’acquisto dell’eredità opera di diritto, senza possibilità quindi di rinuncia, con l’unica prerogativa che lo Stato non potrà mai rispondere dei rapporti passivi oltre il valore dei beni acquistati.
Articolo del:
